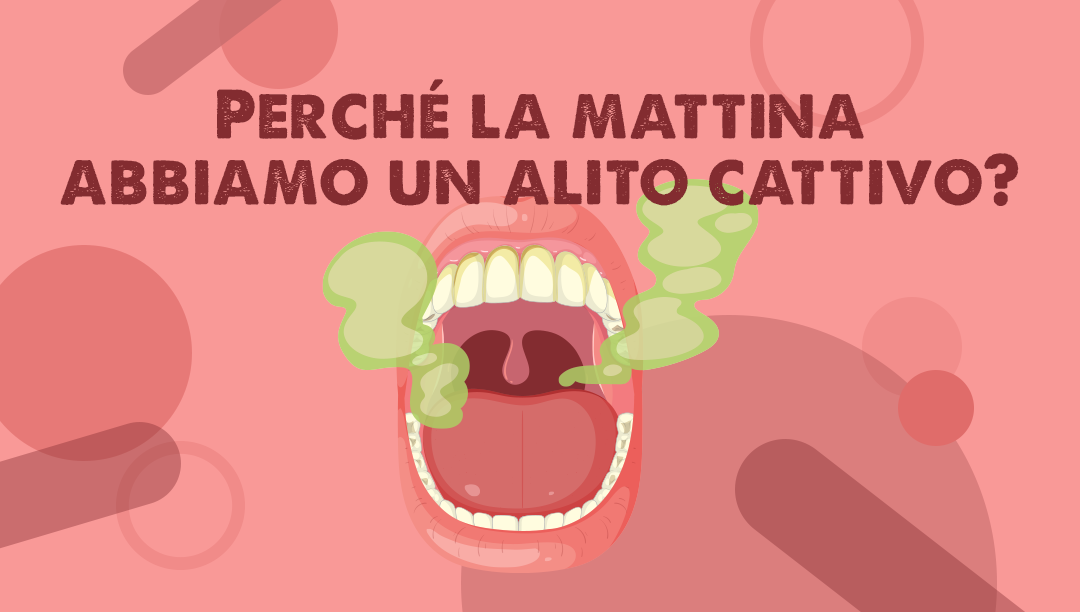Diamo per scontato che cucinare sia usare il calore per trasformare le materie prime in buoni piatti. Eppure, le alte temperature travolgono gli ingredienti per modificarli in diversi modi: ne influenzano la texture, il sapore, i nutrienti, la digeribilità. Sono in grado di dare forma a molecole che non esisterebbero senza il loro intervento.
In questo articolo esploreremo gli effetti e l’influenza del calore sugli alimenti e faremo un esperimento scientifico sullo scioglimento di sostanze solide in liquidi, un fenomeno tanto semplice quanto essenziale per molte preparazioni culinarie.
Comprendere questi processi ci permette di migliorare le nostre abilità in cucina, creando piatti migliori con meno sforzo!
Una questione fisica: i cambiamenti di stato
Il calore è un potente agente capace di causare i cosiddetti cambiamenti di stato nella materia, fondamentali per molte tecniche culinarie. Classico esempio è la trasformazione di un solido in liquido. Il ghiaccio diventa acqua quando viene riscaldato e, così facendo, assorbe energia in un processo noto come fusione. Il calore può poi spingersi oltre, trasformando l’acqua in vapore attraverso l’evaporazione. Accade quando l’acqua raggiunge il punto di ebollizione e le molecole si muovono abbastanza velocemente da sfuggire nella fase gassosa. L’acqua è naturalmente un esempio su tutti, ça va sans dire.
Questi cambiamenti di stato sono affascinanti dal punto di vista scientifico, ma sono anche la base per molte preparazioni culinarie. La fusione del burro è spesso uno dei primi passi nella preparazione di salse e dolci, mentre l’evaporazione dell’acqua è essenziale per la concentrazione dei sapori nelle riduzioni e nelle salse. Un altro esempio pratico che coinvolge un cambiamento di stato è la fusione del formaggio. Quando prepariamo una fonduta o una salsa al formaggio, il formaggio solido riscaldato passa allo stato liquido e può essere amalgamato con altri ingredienti per creare mix di sapori. Se lo desideriamo, possiamo poi passarlo sotto il grill rovente del forno o farlo raffreddare. Lo stato fisico del formaggio cambierà una volta di più e otterremo un piatto dalle consistenze ancora diverse.
Durante questi cambiamenti, a seconda degli ingredienti da cui partiamo, le reazioni chimiche che avvengono somigliano alle infinite lavagne delle aule universitarie dei film, su cui i professori iniziano a scrivere, per staccare il gesso lunghe – e soporifere – ore dopo. Sul fuoco quelle stesse reazioni possono avvenire in pochi minuti o, addirittura, secondi.
Passiamo in rassegna alcune delle più importanti trasformazioni chimiche che avvengono in cucina grazie al calore!
Gli effetti chimici del calore sugli alimenti
DENATURAZIONE DELLE PROTEINE
Le proteine sono molecole più o meno complesse che possiamo trovare in moltissimi alimenti. Recentemente la moda vuole che siano associate al termine fit sottintendendo che fanno bene, meglio anzi, di altri importantissimi nutrienti come i carboidrati. E così pasta, pane e derivati della farina vengono guardati di sottecchi preferendo loro alimenti ad alto contenuto proteico. Questo concetto non ha alcuna ragione di esistere, dal punto di vista scientifico. Peraltro, gli stessi farinacei contengono una certa percentuale di proteine, e mica poche: nella farina di grano in media ne troviamo 14g su 100g di prodotto! Attenti quando riduciamo un alimento, complesso nella sua interezza, a una semplice molecola: quasi sempre avremo torto.
Le proteine contenute nei diversi alimenti sono moltissime, ma tutte sono costruite con un mix di mattoncini chiamati aminoacidi. Dico mix perché di aminoacidi ne esistono 20 diversi in natura, e possono combinarsi in modo diverso e con diverse percentuali a seconda della proteina che devono comporre. A seconda dell’alimento che considereremo, troveremo un mix di proteine diverso!
E cosa succede quando le scaldiamo?
Quando vengono sottoposte al calore le proteine tendono a denaturare, cioè perdono quella che era la loro conformazione spaziale. Infatti, gli atomi che le compongono si legano tra loro formando strutture anche molto grandi – nella scala delle molecole, si intende – e arzigogolate. Il modo preciso in cui le proteine si dispongono nello spazio, la loro forma, è essenziale affinché possano svolgere la loro funzione, cioè il compito per cui vengono sintetizzate da un cereale o un legume, animale o ortaggio. I legami degli atomi che compongono queste molecole vengono fortemente influenzati dal calore, che riesce a romperli facendo srotolare e intrecciare diversamente gli aminoacidi. Il risultato in cucina può essere diverso a seconda dell’ingrediente che stiamo trattando e della sua interazione con le altre molecole che si trovano in pentola.
Un esempio di denaturazione di proteine visibile ad occhio nudo?
La cottura delle uova! L’albume, quando da trasparente diventa bianco, è la prova visiva della denaturazione delle proteine che contiene. Questo ci suggerisce anche che la forma che le proteine hanno influenza il modo in cui la luce viene intrappolata e riflessa, così come il suo profumo e sapore. Chi mangia uova crude, sa di cosa parlo. Io no, non sono in grado di consumare uova crude ma insomma, è risaputo!
Altri esempi visivi di denaturazione proteica durante la cottura sono i colori che assumono il pesce o la carne. Il pesce, da traslucido e liscio, morbido, diviene di colore più intenso, opaco e friabile al tocco. La carne rossa vira verso il marrone quando ben cotta, e ha una consistenza più compatta. E poi ci sono i formaggi, che possono filare, sciogliersi nel solvente o formare grumi a seconda della quantità di proteine che contengono e alla quantità di acqua che contengono.
La cagliata, di cui abbiamo parlato nell’articolo in cui spiegavo come si fanno i formaggi, è proprio il prodotto della denaturazione delle proteine del latte ad opera di un agente che ha questo potere: far loro perdere la struttura originaria e trasformarli in una sottospecie di rete!
CARAMELLIZZAZIONE O DEGRADAZIONE DEGLI ZUCCHERI
Abbiamo visto che esistono tantissime proteine diverse, composte da mix di aminoacidi unici e che possono dare risultati molto diversi tra loro. Al contrario la caramellizzazione parte da pochissime molecole: il saccarosio, cioè lo zucchero da cucina, oppure il glucosio o il fruttosio. Basta una sola di queste molecole a rendere possibile la caramellizzazione, e il risultato è la formazione di migliaia di composti diversi la cui precisa composizione e struttura è ancora in parte sconosciuta ai chimici. Sappiamo che il diacetile è responsabile delle note burrose del caramello, e che ci sono qualcosa come un centinaio di molecole diverse responsabili solo del suo colore marrone!
Lo zucchero comincia a liquefarsi a 160°C. Le sue molecole cominciano a rompersi e i frammenti reagiscono tra loro formando tutta una serie di composti bruni aromatici. Mentre la temperatura sale e le molecole di zucchero si rompono, c’è un momento intermedio in cui prestare attenzione perché la consistenza del tutto sembrerà un grosso grumo di cristalli. Serviranno un po’ di tempo e pazienza per vedere liquefarsi il composto. Dopodiché, a seconda del momento in cui fermeremo la cottura si otterrà un composto di un colore che va dal giallo fino al rosso cupo, bruno o, se è stato scaldato troppo e ha iniziato a degradarsi, ebano. Ecco, se arriviamo a questo punto forse è meglio non consumare il caramello, che conterrà molecole potenzialmente pericolose.
GELATINIZZAZIONE DEGLI AMIDI
Li troviamo in pasta, pane, focacce, riso, patate e in generale tutti i cereali: quando li mangiamo, stiamo facendo scorta di amidi!
Cos’è l’amido?
L’amido è un carboidrato complesso insolubile in acqua che viene utilizzato come riserva di energia nelle cellule vegetali. È la più importante fonte di carboidrati che possono essere assorbiti e utilizzati dal metabolismo cellulare umano. L’amido si trova in gran quantità nei vegetali come tuberi, cereali e legumi ed è costituito a sua volta da due zuccheri chiamati amilosio e amilopectina. L’amilosio e l’amilopectina all’interno del granulo di amido sono insolubili a temperatura ambiente e non possono essere digeriti dai nostri enzimi. Perché diventino digeribili, la struttura cristallina dell’amido deve modificarsi “rompendosi” e assumendo le caratteristiche di un gel: da qui, il termine gelatinizzazione.
La gelatinizzazione dell’amido è possibile per riscaldamento in acqua: l’amido si idrata, si gonfia e perde la struttura cristallina. Poiché amilosio e amilopectina si legano all’acqua, durante la cottura di pane, pasta, ecc. si osserva una diminuzione dell’acqua libera.
L’amido gelatinizzato forma una massa che è in grado di inglobare altre sostanze, dandoci così la possibilità di creare numerose pietanze diverse o di addensare cibi che ci sembrino troppo liquidi.
Curiosità: è possibile fare una parte della preparazione della pasta in acqua fredda, lasciandola in ammollo. Lo so, fa storcere il naso, ma può essere interessante sperimentare acque aromatizzate i cui sapori si impregneranno nella pasta. Oppure si può provare la cottura al microonde, di cui si trovano diverse versioni sui motori di ricerca. Anche se distante dalla nostra tradizione, tutto può essere una scusa per trasformare la cucina in un laboratorio e testare le diverse cotture!
È questo che fanno i grandi chef.
Gli effetti del calore sugli alimenti: conclusioni
In questi tre paragrafi abbiamo visto alcuni esempi di come il calore agisca sulle molecole fondamentali degli alimenti, pur saltandone diversi. Pensiamo ad esempio ai grassi, che qui non abbiamo toccato, e a come cuocendo verdure o carne in una pentola ben calda l’olio, o il burro, siano in grado di estrarre ed intensificare aromi e profumi. O alle reazioni di Maillard, una serie complicatissima di trasformazioni in cottura che coinvolgono i cibi al cui interno si trovano zuccheri e proteine: carne, pane e fritture sono solo pochi esempi. Pensiamo alla crosticina bruna e profumata, agli aromi che invadono la cucina durante queste preparazioni. Sono le reazioni di Maillard, proprio quelle che fanno venire l’acquolina in bocca al sol pensiero!
Saper controllare il calore è importante anche nelle questioni di sicurezza alimentare, dove ad esempio:
- Grazie all’uso di alte temperature in determinate condizioni la nostra specie è riuscita a comprendere come sterilizzare alcuni tipi di alimenti, allungando la loro durata
- Un uso errato della temperatura può provocare la formazione di composti dannosi per la salute, come la crosticina nera del bruciato. Carne, pane, patatine, verdura, qualsiasi alimento che rimane troppo sul fuoco può bruciare ed ecco che si fomeranno una serie di molecole pericolose e potenzialmente cancerogene, come l’acrilammide.
- In alcuni casi, il calore può accelerare la decomposizione degli alimenti, specialmente se non vengono conservati correttamente o se esposti a temperature elevate per lunghi periodi di tempo.
- Più in generale, la cottura di diversi alimenti ne garantisce la sicurezza dal punto di vista microbiologico e aumenta la digeribilità di molte pietanze.
Come potevamo aspettarci, sono davvero troppi gli effetti del calore sugli alimenti per trattarli in questo articolo, ma basti sapere che ci sono e averne, perlomeno, un’infarinatura generale.
Ma ora passiamo alla pratica!
Esperimenti in cucina: la crema di pecorino
I formaggi sono formati da un reticolo di proteine costituito principalmente da caseine. Questo reticolo intrappola l’acqua e i grassi al suo interno: la proporzione con cui si trovano queste molecole ci aiuta a capire se quel formaggio si scioglierà in modo cremoso e omogeneo, se manterrà in parte la sua struttura o se inizierà a filare.
Noi useremo il pecorino, preferendone uno mediamente stagionato che non contiene alte percentuali di acqua, ma neanche minime. Questo ci permetterà, se scaldato dolcemente, di trasformarlo in una crema. Ricordiamoci che più un formaggio è stagionato e più facile sarà che si formino grumi, quindi scegliamo con attenzione. Vediamo come fare la crema!
hanno bisogno di temperature più alte per rompere i legami tra le proteine. Se scaldiamo troppo le proteine coagulano tra loro formando dei grumi ed espellendo l’acqua.
Ingredienti:
- 50 grammi di pecorino romano semi stagionato
- 65 grammi di acqua bollente
- Ciotolina (adatta a bagnomaria)
- Pentolino
Procedimento:
- Portiamo a bollore l’acqua in un pentolino, nel frattempo grattugiamo il formaggio e mettiamolo in una ciotolina. Quando l’acqua bolle, versiamola nella ciotolina con il parmigiano e mescoliamo energicamente, quasi a ottenere un’emulsione. Nel pentolino lasciamo un po’ di acqua bollente, ci servirà dopo. Probabilmente non otterremo un composto del tutto omogeneo, ma il risultato non sarà male.
Commento scientifico: versando l’acqua calda, i grassi del formaggio hanno iniziato a sciogliersi e la maglia di proteine, già frantumata dalla grattugia, ha allentato ulteriormente la presa permettendo a grassi e acqua di scorrere fuori dalla maglia. Per rompere del tutto la rete dobbiamo aumentare ancora un poco la temperatura, ma senza esagerare: se portassimo il composto ad alte temperature, si formerebbero i grumi!
- Poniamo allora la ciotolina dentro il pentolino in cui avevamo fatto bollire l’acqua per scaldare a bagnomaria il pecorino. Teniamo il fuoco spento però, così da controllare meglio l’aumento di temperatura. Se avete un termometro da cucina, potete misurare la temperatura: quando arriveremo a 55 °C raggiungeremo la consistenza cremosa ideale!Se non avete il termometro, poco male: gli occhi saranno il vostro migliore strumento per guidarvi in questo esperimento. Provate anche più volte fino a ottenere il risultato che più vi soddisfa. Le mie indicazioni sono parziali perché tutto dipenderà anche dal formaggio che avrete acquistato!
E dopo?
Non avrete che da scegliere se spalmare la vostra crema su un crostone di pane o farla saltare nella vostra pasta al dente appena scolata.
Tip scientifica?
Al posto dell’acqua portata a ebollizione potete usare quella di cottura della pasta che contiene amido. L’amido ha l’effetto di stabilizzare la rete di proteine del formaggio rendendo più difficile la loro coagulazione! L’amido in polvere è anche utilizzato per far addensare le salse e può essere usato per fare la fonduta di formaggio!